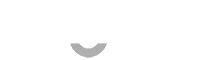La minaccia dei dazi rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci nella strategia commerciale di Donald Trump, tornato alla Casa Bianca con rinnovata determinazione a ridisegnare gli equilibri economici globali. Ma dietro l’apparente semplicità di questa leva protezionistica si nasconde una realtà complessa che spiega perché il presidente americano può permettersi di giocare una partita così aggressiva, mentre l’Europa si trova sostanzialmente disarmata di fronte a questa sfida.
La forza nascosta dei numeri americani
Il segreto del successo della strategia daziaria trumpiana risiede in una caratteristica spesso sottovalutata dell’economia statunitense: la sua straordinaria capacità di autosufficienza. I numeri del Trade Openness Index della Banca Mondiale rivelano una disparità clamorosa. Mentre per la Germania esportazioni e importazioni raggiungono addirittura il 90% del PIL, e per Italia e Francia il commercio estero vale il 68% del PIL, per gli Stati Uniti questo valore si ferma al 27%. Neanche un terzo del PIL americano è legato al commercio con il resto del mondo. Questa peculiarità strutturale conferisce a Washington un margine di manovra che altri attori globali semplicemente non possiedono.
Quando Trump minaccia dazi del 10, 20 o persino 60 percento su determinate categorie di beni, può permetterselo perché l’impatto diretto sul tessuto economico interno rimane gestibile. L’economia americana, con la sua vasta domanda interna e la sua diversificazione settoriale, può assorbire gli shock derivanti da una riduzione delle importazioni molto meglio di economie più aperte e dipendenti dagli scambi commerciali.
Questa resilienza non è casuale, ma deriva da decenni di politiche che hanno mantenuto un mercato interno robusto e diversificato. Il settore dei servizi, che rappresenta la componente predominante dell’economia statunitense, è per sua natura meno esposto alle fluttuazioni del commercio internazionale rispetto al manifatturiero. Inoltre, la presenza di un mercato finanziario profondo e liquido offre alternative di investimento e crescita che non dipendono necessariamente dalla performance del settore esposto alla concorrenza internazionale.
L’asimmetria della vulnerabilità
L’Europa si trova invece in una posizione diametralmente opposta. Le economie del Vecchio Continente hanno costruito la propria prosperità su un modello di integrazione commerciale che, se da un lato ha garantito crescita e benessere, dall’altro ha creato una dipendenza strutturale dagli scambi internazionali. Germania, Paesi Bassi, Belgio: le economie trainanti dell’Unione Europea sono anche quelle più esposte alle turbolenze del commercio globale.
Ma l’Europa non è sola in questa vulnerabilità. Il Canada, con un Trade Openness Index del 67% praticamente identico a quello di Italia e Francia, ha già mostrato i limiti di una reazione aggressiva: il premier Mark Carney, inizialmente percepito come un potenziale sfidante di Trump, ha rapidamente battuto in ritirata cancellando un progetto di tassa digitale che avrebbe penalizzato le multinazionali americane. Il Giappone, con un indice del 47% – comunque quasi doppio rispetto alla dipendenza statunitense – reagisce con la stessa cautela diplomatica di Bruxelles, nonostante l’indignazione dell’opinione pubblica nipponica.
Questa asimmetria si manifesta in modo particolarmente evidente nel rapporto transatlantico. Mentre per gli Stati Uniti l’Europa rappresenta un partner commerciale importante ma non indispensabile, per molti paesi europei il mercato americano costituisce una componente vitale della propria strategia di crescita. Le esportazioni europee verso gli Stati Uniti, dal settore automobilistico a quello farmaceutico, dalle macchine utensili ai beni di lusso, generano una quota significativa del valore aggiunto di interi comparti industriali.
Questa dipendenza assume contorni ancora più preoccupanti se si considera la natura dei prodotti europei diretti negli Stati Uniti. Si tratta spesso di beni ad alto valore aggiunto, frutto di investimenti significativi in ricerca e sviluppo, che difficilmente possono essere reindirizzati verso mercati alternativi nel breve termine. Un’automobile tedesca progettata per soddisfare i gusti e le normative del mercato americano non può essere semplicemente “rietichettata” per la Cina o l’India.
L’impossibilità di una grande coalizione
Una delle conseguenze più significative di questa asimmetria è l‘impossibilità di costruire una grande coalizione internazionale contro le politiche daziarie americane. Dal dopoguerra, gli Stati Uniti hanno svolto il ruolo di “compratore di ultima istanza”, il mercato più aperto che assorbiva le merci altrui trainando la crescita globale. Tutti i paesi che hanno costruito modelli economici basati sull’export hanno fatto affidamento su questa apertura americana, rendendoli poco inclini ad allearsi contro Washington.
Anche la Cina, nonostante la sua forza economica, non rappresenta un’alternativa credibile come alleato europeo. Pechino sta infatti rovesciando sui mercati europei la propria sovrapproduzione, mettendo in crisi settori strategici come l’industria automobilistica europea. Il fenomeno non è nuovo: la Cina ha già seguito questo schema nel tessile-abbigliamento, nell’arredamento, negli elettrodomestici, nell’elettronica e nei pannelli solari. Una partnership con Pechino significherebbe per l’Europa saltare dalla padella alla brace.
Le armi spuntate dell’Europa
Di fronte a questa sfida, l’Europa si scopre drammaticamente limitata nelle proprie opzioni di risposta. Secondo le previsioni del think tank Eurasia Group, Bruxelles continuerà a privilegiare la ricerca di un accordo, preparando comunque misure di ritorsione come deterrente negoziale. La strategia europea prevede di accettare una tariffa di base americana del 10%, puntando a ottenere esenzioni settoriali e a ridurre l’aliquota effettiva attraverso quote e protezioni per i settori strategici: aeronautica, metallurgia, automotive, macchinari e agricoltura.
Le contromisure europee, quando arriveranno, saranno calibrate: dazi di ritorsione su beni americani per un valore fino a 116 miliardi di euro, l’utilizzo dell’Anti-Coercion Instrument (ACI) contro le esportazioni di servizi statunitensi, e la possibilità di estendere le misure a un secondo pacchetto di beni americani del valore di 95 miliardi di euro. Tuttavia, anche questi strumenti riflettono la fondamentale asimmetria del rapporto: sono più minacce negoziali che vere armi di guerra commerciale.
Ma il problema va oltre la lentezza decisionale. L’Europa manca anche degli strumenti economici per infliggere danni comparabili a quelli che può subire. Le importazioni europee dagli Stati Uniti, pur significative, rappresentano una frazione meno critica dell’economia americana rispetto a quanto le esportazioni europee rappresentino per l’Europa stessa. Eventuali dazi europei su prodotti americani potrebbero certamente creare fastidi, ma difficilmente raggiungerebbero l’intensità necessaria per modificare sostanzialmente il calcolo politico di Washington.
Inoltre, molte delle importazioni europee dagli Stati Uniti riguardano settori in cui alternative facilmente disponibili sono limitate. Il gas naturale liquefatto americano, ad esempio, è diventato cruciale per la sicurezza energetica europea dopo la crisi ucraina. Tassarlo significherebbe infliggere danni maggiori ai consumatori europei che ai produttori americani.
La trappola della frammentazione
Un altro elemento che complica la posizione europea è la frammentazione del mercato interno. Nonostante decenni di integrazione, l’Unione Europea rimane un mosaico di economie nazionali con caratteristiche e interessi spesso divergenti. Questa diversità, che in tempi normali rappresenta una ricchezza, diventa un elemento di debolezza quando si tratta di rispondere in modo unitario a pressioni esterne.
I paesi dell’Europa orientale, con economie meno sviluppate e maggiormente dipendenti dagli investimenti stranieri, potrebbero vedere nei dazi americani un’opportunità per attrarre produzioni delocalizzate dall’Europa occidentale. Le economie nordiche, tradizionalmente più atlantiste, potrebbero essere riluttanti ad adottare misure che compromettano i rapporti con Washington. I paesi del Sud, ancora alle prese con le conseguenze della crisi finanziaria, potrebbero privilegiare soluzioni che non mettano a rischio la propria stabilità economica.
Ripensare la strategia europea
In questo contesto, l’Europa si trova di fronte alla necessità di ripensare radicalmente la propria strategia commerciale e geopolitica. La risposta non può limitarsi a misure tattiche di breve termine, ma deve affrontare le cause strutturali della propria vulnerabilità. E questo mette a nudo l’eterogeneità degli interessi dei Paesi UE, problema non di poco conto.
Una prima direzione potrebbe essere quella di accelerare l’integrazione del mercato interno, riducendo le frammentazioni che impediscono all’Europa di esprimere tutto il proprio potenziale economico. Un mercato unico davvero integrato, dall’energia alle telecomunicazioni, dai servizi finanziari alla difesa, potrebbe offrire alle imprese europee quella massa critica necessaria per competere su scala globale senza dipendere eccessivamente da mercati esterni.
Parallelamente, l’Europa dovrebbe investire massicciamente nella diversificazione geografica dei propri rapporti commerciali. Le incertezze sui rapporti transatlantici stanno già spingendo Bruxelles in questa direzione: l’accelerazione del patto commerciale con il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), nuovi accordi con l’Australia e il rafforzamento della cooperazione con altri partner del G7 rappresentano passi concreti verso una maggiore indipendenza dal mercato americano. Tuttavia, questa diversificazione richiede non solo accordi commerciali, ma anche investimenti in infrastrutture, formazione e trasferimento tecnologico che vadano ben oltre la logica del libero scambio tradizionale.
L’innovazione come risposta strategica
Forse, però, la risposta più efficace alle pressioni daziarie americane risiede nell’accelerazione dell’innovazione tecnologica europea. Se l’Europa riuscisse a conquistare posizioni di leadership in settori chiave come l’intelligenza artificiale, le tecnologie verdi, la biotecnologia o la mobilità sostenibile, potrebbe ridurre la propria vulnerabilità creando dipendenze inverse.
Gli Stati Uniti stessi, nonostante la loro forza economica, non possono permettersi di isolarsi completamente dalle tecnologie europee se queste diventassero indispensabili per la competitività americana. L’esempio delle tecnologie per la transizione energetica è emblematico: mentre Trump può tassare le automobili tedesche, difficilmente può permettersi di rinunciare alle tecnologie europee per l’eolico offshore o l’idrogeno verde se vuole mantenere la competitività dell’industria americana.
Una sovranità economica europea
La cautela di Bruxelles, spesso interpretata come debolezza, rappresenta in realtà la presa d’atto realistica di un margine di manovra limitato. Come nota l’analisi di Eurasia Group, la probabilità di uno scenario di “tregua” negoziale rimane al 50%, mentre quella di una vera “guerra commerciale” si ferma al 10%. Questa valutazione riflette la comprensione europea che, in una guerra di ritorsioni a catena, occhio per occhio e dente per dente, il danno che l’America può infliggere è molto superiore al danno che altri le possono restituire.
La sfida dei dazi trumpiani potrebbe rappresentare, paradossalmente, un’opportunità per l’Europa di accelerare quel processo di costruzione della sovranità economica che fino ad oggi è proceduto a rilento. La pressione esterna potrebbe catalizzare quei cambiamenti strutturali che la politica europea non è riuscita a realizzare nei momenti di relativa tranquillità.
Ciò non significa necessariamente abbracciare il protezionismo o chiudersi al mondo, ma piuttosto costruire una base economica sufficientemente solida e diversificata da permettere all’Europa di negoziare da una posizione di forza. Si può deprecare che Trump stia trascinando il mondo in un nuovo paradigma economico fondato esplicitamente sui rapporti di forza, ma i segnali di questa trasformazione si accumulavano da tempo, ben prima del suo precedente mandato.
Solo quando l’Europa avrà ridotto le proprie vulnerabilità strutturali potrà trasformare i dazi da minaccia esistenziale a semplice strumento di negoziazione tra pari. La partita che si sta giocando va ben oltre la questione commerciale: è una competizione per definire quale modello economico prevarrà nel XXI secolo. L’Europa ha ancora le carte per vincere questa partita o almeno giocarsela alla pari, ma deve farlo con maggiore determinazione e visione strategica di quanto abbia fatto finora, accettando che le vecchie regole del gioco sono cambiate definitivamente.