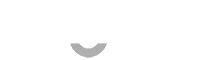A proposito di sovranità digitale, la risoluzione della controversia TikTok tra Stati Uniti e Cina rappresenta un caso di studio unico per comprendere come i concetti tradizionali di sovranità e proiezione del potere vengono ridefiniti nell’era digitale. Merita allora esaminare le implicazioni strategiche del controllo algoritmico, la tensione tra imperativi politici interni e pianificazione strategica di lungo periodo, e le conseguenze più ampie per l’ordine internazionale in evoluzione.
Come ridefinire la sovranità nell’era digitale
Il concetto di sovranità digitale si è evoluto considerevolmente dal sistema westfaliano che stabilì nel 1648 il principio del controllo territoriale. Nell’era digitale stiamo assistendo a quello che studiosi come Susan Strange avevano anticipato nei loro lavori sul “potere strutturale”, ovvero l’emergere di nuove forme di controllo che trascendono i confini territoriali tradizionali.
Il caso TikTok illustra questa trasformazione. Con oltre 170 milioni di utenti americani, la piattaforma rappresenta quello che potremmo definire “territorio algoritmico” cioè uno spazio dove l’influenza viene esercitata non attraverso presenza fisica, ma mediante la cura e la distribuzione dell’informazione. Il che solleva interrogativi fondamentali su come concettualizzare il tema della sovranità digitale allorché gli spazi preponderanti nella vita dei cittadini si spostano in domini digitali anziché fisici.
Quadro teorico: potere algoritmico e asimmetrie informative
Il concetto di “soft power” di Joseph Nye richiede dunque un aggiornamento per l’era digitale. Dove Nye si concentrava sull’attrazione attraverso cultura, valori e politiche, il potere algoritmico opera attraverso meccanismi più sottili di direzione dell’attenzione e del modellamento delle preferenze. L’algoritmo diventa quello che potremmo chiamare “potere infrastrutturale” ovvero assume la capacità di stabilire i parametri entro cui vengono fatte le scelte, spesso senza la consapevolezza di chi viene influenzato.
Questo rappresenta una forma qualitativamente diversa di influenza rispetto ai media tradizionali. Televisione e stampa operavano attraverso il gatekeeping editoriale; gli algoritmi operano attraverso predizione comportamentale e modificazione. I loop di feedback sono più stretti, la personalizzazione più granulare e la scala senza precedenti.
L’asimmetria informativa è cruciale. Mentre gli utenti generano i dati che alimentano l’algoritmo, rimangono largamente ignoranti di come quei dati modellino il loro successivo ambiente informativo. Cosa che crea quello che studiosi del capitalismo della sorveglianza come Shoshana Zuboff descrivono come “estrazione” – l’appropriazione di dati comportamentali per scopi di influenza.
Il paradosso strategico: politica interna vs pianificazione di lungo periodo
La teoria dei giochi a due livelli di Robert Putnam fornisce un quadro utile per comprendere l’approccio americano alla questione TikTok. La sfida per i leader democratici è gestire simultaneamente le pressioni politiche interne mentre perseguono strategie internazionali coerenti.
Le evidenze suggeriscono che considerazioni elettorali possano aver prevalso sull’analisi strategica nella risoluzione TikTok. I sondaggi mostravano costantemente preoccupazione pubblica americana riguardo l’influenza cinese attraverso le piattaforme social. Tuttavia, la soluzione proposta – mantenere la proprietà americana preservando il controllo algoritmico cinese – sembra affrontare la dimensione simbolica del problema lasciando largamente intatte le preoccupazioni sostanziali.
Questo riflette quello che potremmo definire il “problema dell’orizzonte temporale democratico.” I sistemi democratici eccellono nel rispondere alle preferenze immediate dei cittadini, ma faticano con la pianificazione strategica di lungo termine che può richiedere costi a breve termine. I sistemi autoritari come quello cinese affrontano la sfida opposta: possono perseguire strategie di lungo termine, ma potrebbero perdere feedback importanti dalla società sull’efficacia delle politiche.
L’approccio strategico cinese: incrementalismo paziente
L’approccio cinese alla controversia TikTok riflette quello che studiosi come Rush Doshi hanno identificato come un pattern di “invasione paziente”: rimodellare gradualmente norme e pratiche internazionali senza scatenare resistenze massive.
La strategia cinese sembra riconoscere che il confronto diretto con il potere americano è controproducente. Invece, Pechino ha costantemente cercato di creare nuovi fatti sul campo che gradualmente spostano la baseline di ciò che è considerato normale o accettabile. L’accordo TikTok, se dovesse reggere, stabilisce un precedente per cui il controllo algoritmico straniero sugli spazi informativi americani è negoziabile piuttosto che inaccettabile.
Questo approccio riflette una comprensione sofisticata delle dinamiche politiche americane. Offrendo compromessi che salvano la faccia e permettono ai politici americani di rivendicare vittorie preservando gli interessi sostanziali cinesi, Pechino sfrutta la tendenza democratica a privilegiare vittorie politiche a breve termine.
Implicazioni per i sistemi di alleanza e l’ordine globale
Le implicazioni più ampie si estendono oltre le relazioni bilaterali USA-Cina. Il caso TikTok invia segnali agli alleati sulle priorità strategiche e competenze americane. Se gli Stati Uniti appaiono incapaci di gestire efficacemente le sfide della sovranità informativa con la Cina, questo solleva interrogativi sulla capacità americana di guidare coalizioni su questioni di governance digitale più ampie.
Gli alleati europei, in particolare, hanno sviluppato approcci propri alla sovranità digitale attraverso quadri come il Digital Services Act e il GDPR. L’approccio americano a TikTok potrebbe accelerare gli sforzi europei per sviluppare capacità di governance digitale indipendenti piuttosto che fare affidamento sulla leadership americana.
E questa frammentazione degli approcci alla governance digitale potrebbe minare gli sforzi per sviluppare risposte occidentali coordinate agli usi autoritari della tecnologia digitale. Il risultato potrebbe quindi essere un ordine digitale più multipolare, con diverse regioni che sviluppano quadri normativi e standard tecnici incompatibili.
Dimensioni economiche e potere di mercato
Le implicazioni economiche meritano analisi separata. L’economia digitale globale assomiglia sempre più a quello che gli economisti chiamano mercato “winner-take-all”, dove effetti di rete e vantaggi sui dati creano fossati potenti attorno alle piattaforme dominanti.
Il successo di TikTok nel mercato americano apre a che innovazione tecnologica ed esperienza utente possono superare le preoccupazioni geopolitiche, almeno nel breve termine. Questo suggerisce che gli approcci puramente normativi alla competizione digitale potrebbero essere insufficienti se non accompagnati da investimenti in alternative competitive.
La struttura di proprietà americana proposta potrebbe dunque affrontare alcune preoccupazioni di sicurezza nazionale preservando il valore economico della piattaforma. Tuttavia, stabilisce anche un precedente per cui aziende straniere possono mantenere controllo su asset tecnologici core soddisfacendo requisiti normativi attraverso strutture di proprietà.
Approcci alternativi e opzioni politiche
Diversi approcci alternativi meritano considerazione:
- Soluzioni tecniche: trasparenza algoritmica open-source, auditing algoritmico obbligatorio, o requisiti per spiegabilità algoritmica potrebbero affrontare preoccupazioni di influenza preservando funzionalità della piattaforma.
- Coordinamento internazionale: quadri multilaterali per governance digitale, simili alla regolazione dei servizi finanziari, potrebbero stabilire standard comuni per trasparenza algoritmica e protezione dati.
- Risposte competitive: investimento governativo in piattaforme alternative o supporto per competitor domestici potrebbero affrontare la concentrazione di mercato evitando confronto normativo diretto.
- Quadri di reciprocità: accesso condizionale ai mercati americani basato su accesso equivalente ai mercati cinesi per piattaforme americane potrebbe riequilibrare le relazioni commerciali digitali.
Direzioni future di ricerca
Questo caso solleva diverse questioni per ricerca futura:
- Come si confrontano i meccanismi di influenza algoritmica in efficacia con forme tradizionali di soft power?
- Quali design istituzionali potrebbero meglio bilanciare responsiveness democratica con pianificazione strategica di lungo termine?
- Come potrebbero adattarsi diritto internazionale e strutture di governance per affrontare sfide di sovranità digitale?
- Quali sono le implicazioni di welfare di governance digitale globale frammentata?
Oltre la sovranità digitale
Il caso TikTok rappresenta più di una disputa bilaterale tra Stati Uniti e Cina. Illumina tensioni fondamentali nel come le società democratiche bilanciano preoccupazioni di sicurezza, interessi economici e libertà individuali nell’era digitale.
La risoluzione sembra privilegiare una gestione politica a breve termine rispetto alla chiarezza strategica di lungo periodo. Cioè qualcosa che può essere una risposta razionale a pressioni politiche immediate, rischia di stabilire precedenti che potrebbero vincolare future opzioni americane nella governance digitale.
Più ampiamente, il caso suggerisce che il sistema internazionale attuale manchi di quadri adeguati per gestire sfide di sovranità digitale.
La posta in gioco si estende oltre qualsiasi singola piattaforma o relazione bilaterale. La questione è se le società democratiche possano sviluppare approcci coerenti alla sovranità digitale che possano presenvare i loro valori mantenendo vantaggi competitivi nell’economia digitale globale. E il caso TikTok suggerisce che questa sfida rimane/rimarrà largamente irrisolta.