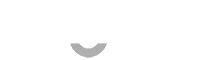Nel Bangladesh del 1976, Muhammad Yunus prestava 27 dollari a quarantadue donne povere per avviare piccole attività commerciali. Quell’esperimento di microcredito gli valse il Nobel per la Pace trent’anni dopo e rivoluzionò l’idea moderna di finanza inclusiva. Ma cinque secoli prima, nei borghi dell’Italia medievale, i francescani avevano già inventato qualcosa di straordinariamente simile: i Monti di Pietà, istituzioni che prestavano denaro ai poveri senza interesse, usando come garanzia pegni di modesto valore e soprattutto la fiducia nella dignità umana.
Non è un caso che questi primi esperimenti di “banca dei poveri” nascano dall’eredità spirituale di Francesco d’Assisi. Il santo che aveva scelto la povertà come via di perfezione aveva seminato, senza saperlo, i germi di una rivoluzione economica che avrebbe attraversato i secoli per arrivare fino ai moderni sistemi di microfinanza.
Il denaro come peccato: l’Europa medievale e l’usura
Per comprendere la portata rivoluzionaria dei Monti di Pietà, bisogna immergersi nell’Europa del XIV e XV secolo, un mondo dove il denaro era insieme necessità assoluta e fonte di profonda angoscia morale. La Chiesa considerava l’usura – qualsiasi prestito a interesse – un peccato mortale, equiparandola al furto e alla simonia. Eppure, l’economia commerciale che stava nascendo richiedeva sempre più capitale circolante.
In questo paradosso vivevano i mercanti cristiani, costretti a navigare tra necessità economiche e salvezza dell’anima. Ma erano soprattutto i poveri a pagare il prezzo più alto di questa contraddizione. Esclusi dai circuiti bancari nascenti, che si rivolgevano ai grandi mercanti, finivano inevitabilmente nelle mani degli usurai, spesso ebrei ai quali la legge canonica non si applicava, o cristiani senza scrupoli che operavano ai margini della legalità.
Prestiti al 40%, al 60%, persino al 100% di interesse annuo erano la norma. Un artigiano che impegnava gli attrezzi del mestiere per affrontare un periodo di crisi rischiava di perdere per sempre la possibilità di lavorare. Una vedova che impegnava l’unico bene di famiglia poteva vedersi costretta a prostituirsi per sopravvivere. L’usura non era solo un problema economico, era una piaga sociale che alimentava povertà, disperazione e criminalità.
Francesco e la rivoluzione della povertà
Quando Francesco Bernardone, figlio di un ricco mercante di Assisi, scelse nel 1206 di abbandonare ogni bene terreno per abbracciare “Madonna Povertà”, non stava solo compiendo una scelta spirituale personale. Stava mettendo in discussione l’intero sistema di valori della società medievale, fondato sull’accumulo di ricchezza come segno di benedizione divina.
La povertà francescana non era rinuncia passiva, ma scelta attiva di solidarietà con gli ultimi. Francesco non si limitava a vivere povero: si faceva povero tra i poveri, trasformando la privazione in strumento di comprensione e condivisione. Lavorava con le mani, chiedeva l’elemosina quando necessario, ma soprattutto predicava con l’esempio che la dignità umana non dipendeva dal possesso di beni materiali.
Questa visione rivoluzionaria ebbe conseguenze che andarono ben oltre la spiritualità. I francescani che seguirono le orme del fondatore svilupparono una sensibilità sociale acuta verso le ingiustizie economiche. Vedevano quotidianamente gli effetti dell’usura sui loro fedeli: famiglie distrutte, artigiani ridotti alla miseria, intere comunità impoverite da debiti insostenibili.
Ma Francesco aveva lasciato ai suoi seguaci qualcosa di più della semplice denuncia: aveva mostrato che esistevano alternative concrete all’economia dell’accumulo. La sua idea di fraternità universale implicava che anche i rapporti economici potessero essere trasformati dalla carità cristiana. Non carità assistenzialista, ma carità “strutturata”, capace di modificare i meccanismi stessi che generavano povertà.
La geniale invenzione: nascono i Monti di Pietà
Fu nel 1462, a Perugia, che un frate francescano di origine fiamminga, Barnaba da Terni, fondò il primo Monte di Pietà della storia. L’idea era rivoluzionaria nella sua semplicità: creare un’istituzione che prestasse denaro ai poveri senza interesse, finanziata dalle donazioni dei fedeli e gestita secondo principi cristiani.
Il meccanismo era ingegnoso quanto innovativo. I cittadini facoltosi venivano invitati a versare denaro in un fondo comune, gestito da amministratori laici sotto la supervisione dei francescani. Questo capitale veniva poi prestato a chi ne aveva bisogno, richiedendo come garanzia un pegno di valore superiore al prestito, ma senza applicare interessi. Dopo un periodo determinato, solitamente un anno, il debitore poteva riscattare il pegno restituendo la somma prestata. Se non riusciva a pagare, il pegno veniva venduto all’asta e l’eventuale differenza restituita al proprietario.
L’innovazione non stava solo nell’assenza di interesse, ma nell’intero sistema di garanzie sociali che ruotava attorno al Monte. I francescani si facevano garanti morali dell’operazione, predicando dalle chiese per sensibilizzare i fedeli. Gli amministratori, scelti tra i cittadini più rispettabili, mettevano la loro reputazione al servizio dell’iniziativa. L’intera comunità diventava così corresponsabile del successo dell’istituzione.
I risultati furono straordinari. Nel giro di pochi decenni, i Monti di Pietà si diffusero in tutta Italia. Firenze nel 1473, Mantova nel 1474, Milano nel 1484, Roma nel 1539. Ogni città voleva il suo Monte, segno che l’innovazione rispondeva a un bisogno reale e diffuso.
Più di una banca: un sistema di welfare medievale
I Monti di Pietà non erano semplicemente istituzioni creditizie alternative. Erano veri e propri sistemi di welfare ante litteram, che integravano assistenza economica, educazione finanziaria e supporto sociale.
Il caso del Monte di Pietà di Bologna, fondato nel 1473, è emblematico. Oltre al prestito su pegno, l’istituzione gestiva un sistema di doti per le ragazze povere che volevano sposarsi o farsi monache, manteneva un ospedale per i pellegrini, finanziava l’educazione dei bambini orfani. Il Monte era diventato il cuore pulsante del sistema di solidarietà cittadino.
Ma l’aspetto più innovativo era l’approccio educativo. I francescani non si limitavano a prestare denaro: spiegavano ai debitori come gestire le proprie finanze, li consigliavano su investimenti e attività commerciali, li aiutavano a pianificare il rimborso. Era un vero e proprio servizio di consulenza finanziaria per i poveri, cinque secoli prima che nascesse il concetto moderno di financial inclusion.
Questa dimensione educativa si basava su principi che oggi chiameremmo di “empowerment”. I francescani credevano che la povertà non fosse una condanna inevitabile, ma spesso il risultato di circostanze sfortunate o di mancanza di opportunità. Fornire credito accessibile significava restituire dignità e possibilità di riscatto sociale.
Le resistenze: quando l’innovazione fa paura
L’espansione dei Monti di Pietà non fu priva di opposizioni. Gli usurai privati vedevano ovviamente nella nuova istituzione una concorrenza sleale che minacciava i loro profitti. Ma anche all’interno della Chiesa sorsero resistenze significative.
Il nodo teologico era delicato: i Monti richiedevano una piccola somma per coprire le spese di gestione, tipicamente il 5-6% annuo. Questo non era tecnicamente un interesse, ma molti teologi rigoristi lo consideravano comunque una forma di usura mascherata. Ne nacque una controversia che durò decenni, con scambi di lettere tra università, predicazioni infuocate e prese di posizione ufficiali.
La questione venne risolta definitivamente nel 1515, quando Papa Leone X con la bolla “Inter multiplices” dichiarò i Monti di Pietà non solo leciti, ma “meritevoli di lode e di approvazione”. La Chiesa riconosceva ufficialmente che la carità poteva essere “strutturata” senza perdere la sua natura virtuosa.
Ma forse la resistenza più sottile veniva da chi vedeva nell’iniziativa francescana una critica implicita all’intero sistema economico dell’epoca. Se era possibile prestare denaro senza interesse e ottenere risultati positivi, che giustificazione morale potevano avere i tassi usurari? Se i poveri potevano essere aiutati attraverso meccanismi di credito, perché non farlo sistematicamente?
L’eredità moderna: dai Monti di Pietà al microcredito
La storia dei Monti di Pietà non si ferma al Medioevo. Molti di questi istituti sono sopravvissuti attraverso i secoli, adattandosi ai cambiamenti economici e sociali. Il Monte dei Paschi di Siena, nato nel 1472, è ancora oggi una delle principali banche italiane. Il Monte di Pietà di Roma, fondato nel 1539, continua a operare nel settore del credito su pegno.
Ma l’eredità più profonda dei Monti è concettuale. L’idea che il credito possa essere uno strumento di giustizia sociale, che i poveri abbiano diritto all’accesso ai servizi finanziari, che la solidarietà possa essere organizzata in forme sostenibili: questi principi attraversano i secoli per riemergere nel microcredito moderno.
Muhammad Yunus, quando nel 1976 iniziò i suoi esperimenti di prestiti ai poveri nel Bangladesh, non conosceva probabilmente la storia dei francescani italiani. Eppure, la sua Grameen Bank riproduce molti dei meccanismi inventati dai Monti di Pietà: credito senza garanzie tradizionali, affidamento sulla fiducia sociale, integrazione tra assistenza economica e educazione finanziaria, coinvolgimento della comunità come garante morale delle operazioni.
Anche le moderne esperienze di finanza etica – dalle banche popolari alle società di investimento sociale – riprendono l’intuizione francescana che l’economia può essere al servizio della persona piuttosto che del profitto. Le cooperative di credito, i sistemi di microcredito, le piattaforme di crowdfunding sociale sono tutte declinazioni contemporanee dell’idea che il denaro possa essere strumento di fraternità anziché di dominio.
Francesco oggi: l’attualità di un’utopia medievale
In un’epoca di crescenti disuguaglianze economiche, di finanziarizzazione spinta dell’economia, di esclusione bancaria per milioni di persone, l’eredità francescana dei Monti di Pietà appare sorprendentemente attuale. Non come nostalgico ritorno al passato, ma come ispirazione per ripensare il ruolo sociale della finanza.
La pandemia di Covid-19 ha mostrato ancora una volta come le crisi economiche colpiscano più duramente chi ha meno risorse e meno accesso al credito. Le misure di sostegno pubblico, per quanto necessarie, hanno spesso faticato a raggiungere davvero gli ultimi. In questo contesto, l’idea di istituzioni finanziarie che mettano al centro la persona anziché il profitto torna a essere non solo eticamente desiderabile, ma economicamente necessaria.
Alcune esperienze contemporanee stanno già sperimentando questa via. Le banche del tempo, i sistemi di moneta locale, le piattaforme di lending sociale ripropongono in forme nuove l’antica intuizione che l’economia può essere spazio di relazione e solidarietà. Start-up come Kiva, che facilita microprestiti internazionali, o piattaforme di crowdfunding come GoFundMe riproducono su scala globale i meccanismi di fiducia sociale che erano alla base dei Monti di Pietà.
La lezione dei secoli: quando la carità diventa sistema
La storia dei Monti di Pietà insegna che le innovazioni più durature non nascono da calcoli economici, ma da visioni morali forti che sanno tradursi in meccanismi concreti ed efficaci. Francesco d’Assisi non aveva elaborato teorie economiche, ma aveva intuito che ogni rapporto umano – anche quello mediato dal denaro – poteva essere trasformato dalla carità.
I francescani che due secoli dopo fondarono i Monti non stavano solo risolvendo un problema tecnico di accesso al credito. Stavano dimostrando che era possibile un’economia diversa, fondata su fiducia anziché su sospetto, su solidarietà anziché su competizione, su inclusione anziché su esclusione.
Questa lezione attraversa i secoli per arrivare fino a noi. In un mondo dove la finanza sembra sempre più autoreferenziale e lontana dai bisogni reali delle persone, l’eredità francescana ci ricorda che l’economia è sempre, in ultima analisi, una questione di relazioni umane. E che queste relazioni possono essere orientate verso la fraternità o verso il dominio, verso l’inclusione o verso l’esclusione, verso la vita o verso la morte.
I Monti di Pietà non erano utopie irrealizzabili, ma esperimenti concreti che hanno funzionato per secoli, dimostrando che un’altra economia è possibile. Non perfetta, non priva di contraddizioni, ma orientata verso una maggiore giustizia sociale.
Oggi, mentre il microcredito si diffonde in tutto il mondo e nuove forme di finanza sociale prendono piede, la memoria di questi antichi pionieri della solidarietà economica non è solo un omaggio alla storia, ma un invito a continuare a sperimentare. Perché l’economia del futuro si costruisce sulla lezione del passato: che la ricchezza più grande di una società non sta nell’accumulo di beni, ma nella capacità di mettere questi beni al servizio di tutti.
Francesco d’Assisi non avrebbe mai immaginato che la sua scelta di povertà avrebbe generato secoli di innovazione finanziaria. Ma forse è proprio questo il segno più profondo della sua grandezza: aver seminato principi così radicali e vitali da continuare a germogliare in forme sempre nuove, adattandosi ai tempi ma mantenendo intatto il nucleo di verità umana che li ha generati.
La carità, quando diventa strutturata e organizzata, non perde la sua natura. La moltiplica.