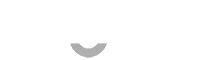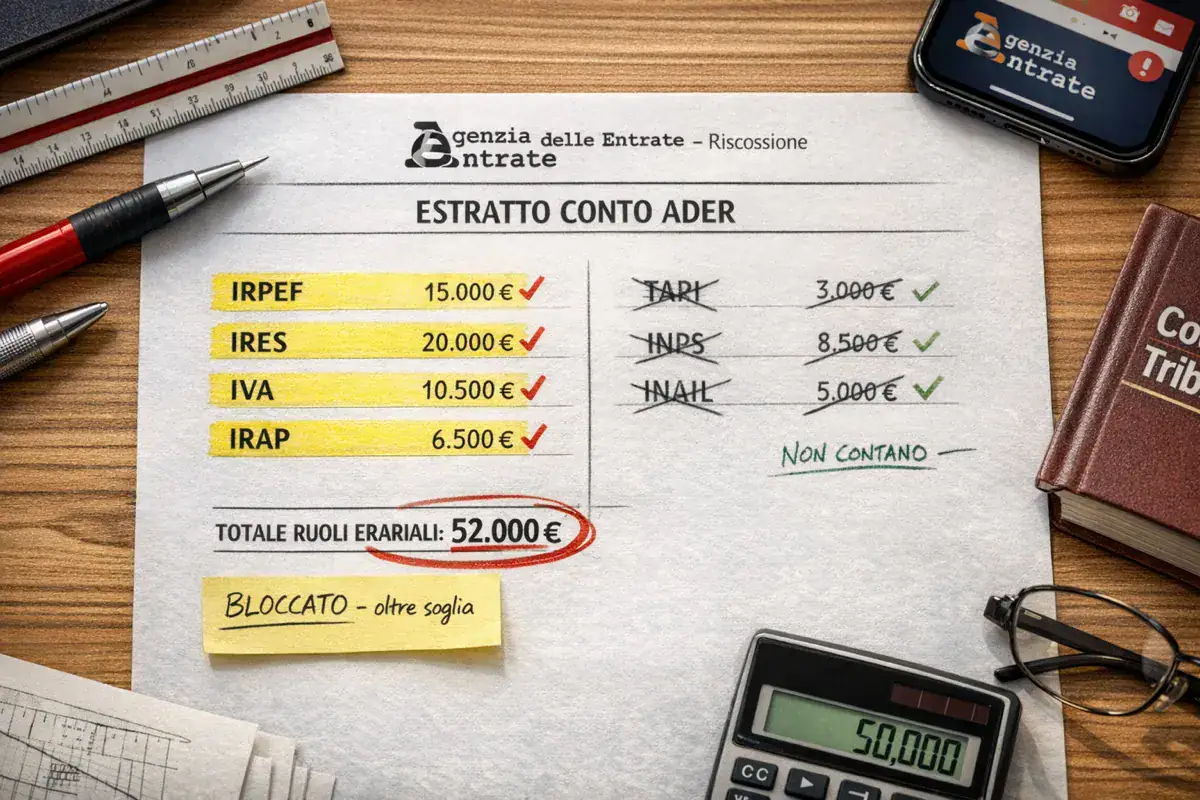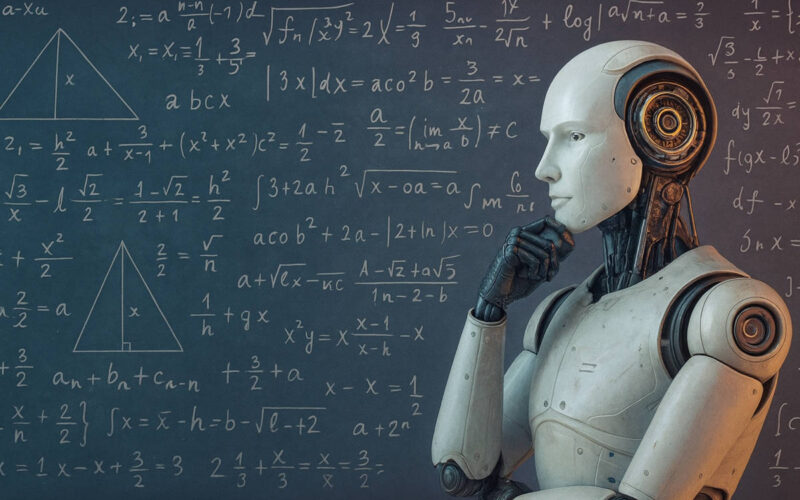Un libro per capire il linguaggio dell’economia
Nel 2023 è uscito un libro intitolato L’italiano dell’economia. L’autore è Riccardo Gualdo, linguista, docente universitario e saggista, che propone un’esauriente storia del lessico economico, dall’antichità all’età contemporanea. È uno studio molto dettagliato e ben documentato dei termini e dei costrutti stilistici e metaforici che danno forma (e contenuto) alla lingua di una disciplina così densa e articolata.
Il Trecento e la nascita del lessico economico
Il Trecento, quasi al crepuscolo del Basso Medioevo, è l’epoca nella quale fioriscono comuni e signorie e compaiono rudimentali prototipi di banche. Mercanti e banchieri intuiscono la necessità di coniare nuovi vocaboli, tratti in gran parte da calchi latini, con rari innesti dal greco e dall’arabo. Alcuni di questi, come credito, debito, mutuo, sconto, capitale e investimento, per citare i principali, sono tuttora usatissimi e sono presenti in numerose lingue europee.
L’evoluzione tra Settecento e Ottocento
Col passare dei secoli e tramontata la supremazia commerciale delle regioni italiane, il vocabolario si arricchisce di ulteriori apporti, in prevalenza provenienti dal mondo anglosassone. La nascita, nel Settecento, della moderna scienza economica implica un’evoluzione del linguaggio in senso specialistico. Poiché Francia prima e Regno Unito poi sono le potenze dominanti, proliferano francesismi ed anglismi.
Il Novecento e l’invasione dei termini inglesi
L’ascesa degli Stati Uniti, tra Novecento e nuovo millennio, comporta, infine, un’alluvione di neologismi derivanti dall’inglese e adottati passivamente, senza il minimo sforzo di traduzione. Oggi siamo inondati da centinaia di sigle e nomi di chiara etimologia british, che rendono ancor più ostica la comprensione delle nozioni base dell’economia. Troviamo voci familiari e diffuse, come spread, asset allocation, hedge fund, start-up, cashback o benchmark. Ci ritorneremo tra qualche riga.
Quando il linguaggio diventa ostico
Passiamo a qualche esempio pratico, anche per saggiare le vostre conoscenze. Partiamo con qualcosa di agevole. Si fa per dire…Il plusvalore generato nel processo di produzione del capitale anticipato si presenta come eccedenza del valore del prodotto sulla somma dei valori degli elementi della sua produzione. Se la lettura di questobrano, estrapolato dal Capitale di Marx, vi lascia perplessi sietegiustificati. Il testo, del 1867, è datato e complicato.
Un esempio di linguaggio finanziario moderno
Proviamo, allora, con qualcosa di più recente. Si conferma la dinamica di mercato fortemente rialzista per il future sull’S&P 500 con scadenza settembre 2025. Dopo aver testato con successo un importante livello di supporto intorno a 5.970, il future ha messo a segno una rottura decisa della resistenza in area 6.130, consolidandosi in modo stabile tra i 6.250 e i 6.350. Ok, stop, vi evitiamo il resto. Se di fronte a questa affermazione brancolate nel buio, non preoccupatevi. È gergo da esperti di trading e nessuno si aspetta da voi questo genere di competenze.
Perché serve conoscere l’ABC dell’economia
Ma l’abc è indispensabile, perché l’Italia, ai vertici delle classifiche mondiali per predisposizione al risparmio, occupa, invece, gli ultimi posti per conoscenze finanziarie. Così riteniamo opportuno sottoporvi una breve guida ai concetti fondamentali di economia e finanza. In modalità ben poco accademica, ma assai pratica. Cominciamo.
Mercati – Dimenticate le sale contrattazioni frenetiche del film Una poltrona per due. Adesso gli scambi si svolgono in ambienti ovattati e sonoregolati da algoritmi automatizzati. Non per questo regna una calma olimpica tra glioperatori, spesso travolti dal caos tipico dei suq mediorientali più pittoreschi.
Azioni – Vige il principio del senno del poi. Gli Italiani sono allergici alle azioni finché non si accorgono dei numeri strabilianti a tripla cifra realizzati da società quotate come Apple, Amazon, Nvidia e solo allora si pentono amaramente di non averle comprate. Tuttavia, quando un consulente suggerisce di investire in un paniere diversificato, per carità…è un azzardo!
Obbligazioni – Al cuor non si comanda, è questa la smisurata passione dei nostri connazionali. Lo sarebbe molto meno se si percepisse qual è la loro autentica natura: un prestito, richiesto da enti, per lo più pubblici, indebitati all’inverosimile. E, quindi, tocca confidare di riavere indietro il proprio denaro, con interessi non sempre allettanti. Un rischio con poco rendimento.
Derivati – Servono alle società di investimento per circoscrivere i rischi o, al contrario, come acceleratori di performance. In mani inesperte sono peggio della nitroglicerina: don’t try this at home!
Conto corrente – Tutti sanno cos’è, ma molti ne sottovalutano le insidie. Una montagna di liquidità giace sui conti bancari in attesa di un miglior impiego. E, in sua assenza, questo eccesso di risparmio verrà eroso da costi, imposte, inflazione e non frutterà un centesimo.
Inflazione – È l’incremento dei prezzi di beni e servizi nel tempo. Ha costituito l’emergenza assoluta negli anni Ottanta del secolo scorso, quindi si è dissolta, per infiammarsi di nuovo durante la pandemia. Disinnescarla è stato difficile e doloroso. L’inflazione intacca il nostro potere d’acquisto, anche quando sembra invisibile ed innocua, come la goccia d’acqua che scava la pietra. Lentamente, ma inesorabilmente.
Banche Centrali – Svolgono una miriade di compiti, tra cui: far funzionare e sorvegliare il sistema bancario, emettere moneta, controllare la stabilità dei prezzi, fissare i tassi d’interesse. Ruolo ingrato, di questi tempi, quello di Governatore di un’istituzione così importante: come si muove, sbaglia e se sta fermo, pure. Martire.
Volatilità – Descrive l’oscillazione del valore di un titolo in un determinato arco temporale e, dunque, ne connota la rischiosità. Un’analogia alquanto abusata, ma efficace, è quella delle montagne russe. Forse vi sorprenderà, ma sull’ottovolante spesso si trovano le obbligazioni e non soltanto le azioni. Allacciare le cinture di sicurezza!
Asset allocation – È il processo di costruzione di un portafoglio di investimento. Il gestore agisce come il cuoco in cucina: seleziona i migliori ingredienti, li mescola, provvede alla giusta cottura e a presentare in modo accattivante i piatti in tavola. Un po’ come a Masterchef, ma con una giuria più rigorosa per verificare se manca un pizzico di sale o se l’impiattamento lascia a desiderare.
Pil – Il Pil (prodotto interno lordo) è l’insieme di beni e servizi che compongono la ricchezza di una nazione. Numeri crudi, che tengono conto dell’economia sommersa, ma non del benessere di un popolo.
Analisi tecnica – Studia l’andamento dei mercati, utilizzando i grafici per individuare le tendenze. D’accordo, ma dove si leggono questi dati? Ovviamente nella sfera di cristallo…
Spread – Vuol dire, alla lettera, ampiezza, estensione, ma si riferisce alla differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a lunga scadenza. A volte la distanza è abissale, oggi ce la caviamo. Magari persino meglio che a pallone.
Rating – È il giudizio che accerta l’affidabilità di un debitore. Una sorta di pagella, mediocre per l’Italia, che porta a casa una sufficienza stiracchiata. Per rimanere in àmbito calcistico, lottiamo per tornare in serie A, ma la zona Champions è lontanissima.
Trading (online) – Di per sé non è una nozione difficile: basta avere un conto apposito per eseguire in autonomia la compravendita di azioni, obbligazioni, valute e derivati. Definita la faccenda, poi le cose si ingarbugliano, perché il trader effettua operazioni misteriose, come, ad esempio, tradare un future. Tradare, per inciso, è il pigro calco italiano del verbo inglese to trade, che vuol dire trattare, negoziare.
Shortare – Anche questo è un goffo prestito dall’inglese. L’ambiente è quello speculativo dei contratti derivati. Chi shorta va corto, e, in sintesi, scommette sulla discesa di un titolo. Ma corto di che? Di sportività forse, poiché tifa contro la direzione comune. Gufo.
Orsi e tori – Questa coppia di sostantivi identifica due fasi di mercato antitetiche. La prima indica ribasso, la seconda rialzo. Qual è l’origine dei nomi? Le due belve attaccano in modi opposti: il Toro incorna verso l’alto, l’orso graffia all’ingiù.
Falchi e colombe – Quest’altra metafora faunistica allude alle diverse vedute tra i membri di una Banca Centrale. I primi spingono per una politica monetaria severa e sono favorevoli ad alzare i tassi d’interesse; le seconde prediligono una linea più morbida, con tassi minimi.
Sentiment di mercato – È, molto prosaicamente, il punto di vista delle case di gestione, ma l’espressione evoca rarefatte e delicate atmosfere romantiche. Per smentire chi sostiene che sui parterre finanziari sia assente la poesia.
Siamo giunti alla conclusione di questa rassegna. Ci auguriamo di avervi strappato un mezzo sorriso e, soprattutto, di essere riusciti a fornire un contributo utile a dissipare la nebbia che circonda l’economia, materia verso la quale ci si pone con diffidenza o disagio, disorientati suppergiù come un turista occidentale al cospetto degli ideogrammi giapponesi. Di rado i mass media e i social si sforzano di spiegare in maniera comprensibile al grande pubblico il gergo iniziatico cui fanno ampio ricorso. Ed è un delitto capitale, perché l’argomento è complesso, ma le sue implicazioni sono essenziali per la vita quotidiana di ciascuno di noi.
La padronanza dei concetti basilari è un obiettivo condivisibile, per le nostre tasche e per la crescita dell’intero Paese. E la semplificazione del codice un dovere per gli addetti ai lavori.